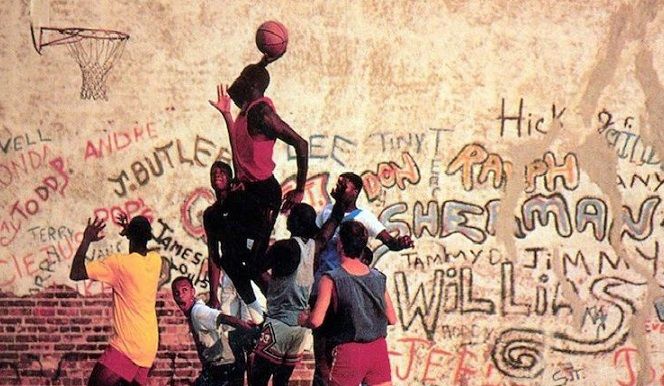Quante volte ci capita di confrontarci per capire come possiamo vivere al meglio la nostra vita? Dovrebbe essere un tema all’ordine del giorno nelle scuole, nelle organizzazioni, nelle famiglie visto che la vita è il bene più prezioso che abbiamo a disposizione. Autorealizzazione può sembrare un temine vago, eppure le persone pongono riflessioni e domande reali e concrete che hanno molto a che fare con questo tema: “Mi piace ciò che faccio, ma non mi basta più”, “Non riesco ad esprimere me stessa dentro questa vita”, “Mi sono chiesto per quale motivo valga la pena di vivere”, “Ho una vita sola e vorrei viverla al meglio”. Queste sono alcune delle affermazioni accolte e raccolte in questi anni che, seppur indicando talvolta un certo malessere, sottolineano il forte desiderio di riuscire a vivere pienamente la propria vita e rappresentano una richiesta di autorealizzazione. Autorealizzarsi significa essere pienamente se stessi, mettere in campo le proprie potenzialità, vivere una vita motivata, ricca di significati ed esprimere il vero sé. In questo senso l’autorealizzazione è la via per perseguire la felicità. Riflettere intorno al tema della felicità e della autorealizzazione a volte ci emoziona, altre ci dà l’impressione di trattare un concetto inafferrabile. Nella vita quotidiana però percepiamo una tensione che fa nascere interrogativi alla ricerca di concretezza: autorealizzarsi è una questione complessa, fatta di consapevolezza, scelte, immaginazione, mete, speranza, ma anche di rischi, di errori e ostacoli, dove il percorso non è tracciato. L’autorealizzazione ha a che fare con l’arte di vivere, implica la competenza di costruire un progetto di vita in cui poter realizzare al meglio le persone che vogliamo essere, le proprie potenzialità e le proprie vocazioni.
Paradigmi disfunzionali: gli ostacoli culturali alla nostra autorealizzazione
Come autorealizzarsi? Ognuno si sperimenta, mette in atto tentativi alla scoperta di ciò che implica questo desiderio. Immediatamente questa spinta è accompagnata da controspinte uguali e contrarie. A volte le controspinte hanno la meglio. Capita così che una madre che si vuole autorealizzare possa temere di essere egoista e quindi vi rinuncia. Oppure accade che qualcuno pensi che nell’autorealizzazione l’affermazione di sé implichi il prevalere sugli altri. O ancora, qualcun altro sente il desiderio di voler essere felice e vorrebbe farlo avendo il supporto di chi lo/la ama e invece si ritrova solo; altri ancora si sentono dire dagli amici “devi pensare prima a te stesso”. La strada è impervia. Non abbiamo una cultura nel merito e quindi i nostri tentativi a volte sono maldestri e si perdono in derive o arrivano ad un bivio: la mia felicità o l’adattamento di sé al contesto e alle esigenze altrui? Come se io e gli altri fossimo su poli opposti. Sembra che la voglia di autorealizzarsi sia spesso accompagnata da un senso di colpa e altre, all’opposto, da un atteggiamento egocentrico e individualista. A volte il percorso di autorealizzazione è reso ancor più complesso da un ulteriore rischio: immaginare una vita autorealizzata e felice caratterizzata dalla semplice somma di emozioni e sentimenti piacevoli e positivi. Anche questa è una trappola legata a una lacuna di competenze. L’autorealizzazione e la felicità non necessariamente eliminano emozioni e sentimenti spiacevoli. Ciò che fa la differenza è la consapevolezza di affrontare un dolore o un sentimento spiacevole dentro una dimensione di ricerca del bene e come parte di esso. Ciò che cambia è avere dei significati che ci guidano, ciò che cambia è immaginare che la mia felicità possa moltiplicare la felicità altrui, e se non accade, devo interrogarmi su quali sono stati i presupposti di queste relazioni e quali gli allenamenti messi in campo. Probabilmente ho vissuto esperienze in cui non mi sono allenata in funzione dei miei valori, o forse i timori e gli adattamenti passivi hanno prevalso o ancora i miei valori erano sbagliati, incompleti, contraddittori, fragili. Allenarsi ad una cultura umanistica dove le nostre
potenzialità diventano valori forti e generativi e come tali hanno anche una funzione etica e relazionale penso sia la chiave di volta per trasformare i nostri tentativi in un percorso soddisfacente.
Sulla natura umana: il parere della scienza
Cosa dice la scienza intorno alla natura umana? Oggi, attraverso le lenti di varie discipline, la scienza disvela la tendenza altruistica degli esseri umani, la spontanea cooperazione e empatia come parte della natura umana. Batson e Eisenberg ad esempio hanno condotto studi in cui sottolineano il comportamento altruistico degli esseri umani. Micheal Tommasello in “Altruisti nati” afferma l’innata tensione dei bambini a considerare i bisogni altrui. Il neonato sembra programmato biologicamente per riconoscere il volto umano e per rispondervi. La Wilson ha sottolineato che l’altruismo fa parte dell’istinto di sopravvivenza. Non solo, alcuni medici affermano il binomio salute-relazionalità, ossia quanto buone relazioni sociali possano portare benefici allo stato di salute (vd. Scherwitz e i rischi nelle coronopatie). Un nuovo studio dell’Università del North Carolina a Chapel Hill con i colleghi della Renmin University a Pechino, sostiene che le relazioni sociali aiutino a vivere più a lungo. Da un’analisi su migliaia di soggetti seguiti per molti anni è infatti emerso che la quantità e la qualità dei rapporti con i propri simili è correlata positivamente a buone condizioni di salute e alla longevità. La stessa teoria intorno ai neuroni a specchio sottolinea la natura eminentemente sociale degli esseri umani che attraverso i neuroni comprendono intenzioni e interpretano sentimenti altrui. Se consideriamo tali studi, porsi la questione di voler realizzare noi stessi, ci porta necessariamente a contemplare anche la nostra natura relazionale. Possiamo autorealizzarci solo coltivando relazioni autentiche. Come afferma Stanchieri pare che la nostra felicità “superiore” sia quella trascendente, ossia l’essere felici rendendo felici gli altri. La nostra felicità personale si moltiplica attraverso l’incontro della felicità dell’altro. La felicità porta con sé necessariamente il tema delle relazioni. La felicità si dà solo insieme agli altri. Si tratta di un compito complesso e difficile da realizzare. La differenza la fa l’allenamento intenzionale quotidiano.
I pionieri dell’autorealizzazione
Essere coach ci dà anche il privilegio di conoscere e a volte allenare i pionieri, coloro che credono che sia possibile attraverso la propria felicità moltiplicare la felicità altrui. Penso ad un’insegnante universitaria che ha ideato un percorso formativo di eccellenza, un progetto sfidante che ha richiesto una mole di lavoro enorme e complessa, per giovani che vogliono diventare imprenditori, dove apprendono le competenze tecniche, ma anche l’importanza dei valori e dell’etica. Perché fa tutto ciò? Perché ciò che la rende felice è dare speranza ai giovani creando per loro occasioni di crescita. La sua felicità trova risposta e si moltiplica nella loro. Oppure penso a Diego imprenditore che desidera fortemente che nella propria azienda le persone stiano bene e si sentano parte della “comunità”, immagina la sua azienda come un luogo dove i suoi collaboratori possano trovare una dimensione di crescita e di serenità, gli piacerebbe dar vita ad un’academy interna per permettere anche ai giovanissimi di sperimentarsi e vuole la felicità dei suoi collaboratori perché in questo modo si sente più felice. Oppure penso a Silvia che si sente realizzata quando porta il sorriso nella vita delle persone. I pionieri sono coloro che si sperimentano di giorno in giorno per segnare il tracciato di un progetto di vita che armonizzi il proprio bene a quello altrui; facendolo scoprono sé stessi e si danno la possibilità di realizzare una “nuova natura” che genera progetti, esperienze e relazioni foriere di felicità per gli altri. Per questi pionieri i progetti, i risultati e l’autosviluppo non avrebbero senso se gli altri non ne traessero benefici.
L’autorealizzazione implica un allenamento intenzionale e creativo
Costruire un progetto di vita significativo implica un allenamento intenzionale: richiede la conoscenza delle proprie potenzialità, dei propri desideri, delle proprie passioni e capire come armonizzarli, ma anche allenare la propria coscienza, intelligenza sentimentale e concezione di bene. Non solo, è necessario imparare come declinare tutto ciò dentro le scelte quotidiane e dentro le relazioni nella complessità che la vita ci pone. In misura più essenziale l’indicatore che ci guida può essere: sto esprimendo al meglio il mio amore per la vita? Siamo come scienziati che fanno ricerca sulla base di teorie: se i risultati sono sempre anomali, incerti, inconcludenti, devianti, non ci resta che cambiare le teorie e fare ricerche su nuove basi. La nostra vita è la verifica pratica delle nostre scelte.
Barbara Mitelli, coach umanista e docente
b.mitelli@ilcoachingumanistico.com
Leggi il profilo completo dell’autore: LINK
A pagina 19 del n.4 di Omega, trovate il Workout elaborato per allenare i vostri significati di vita.